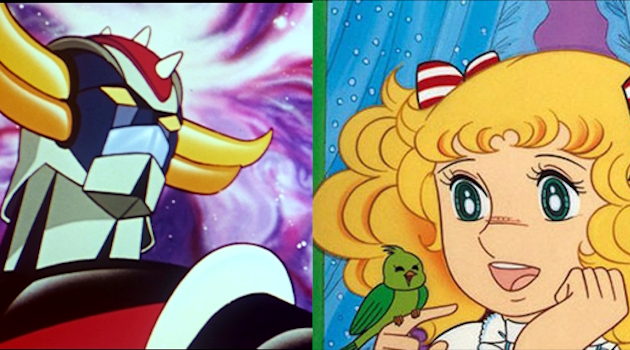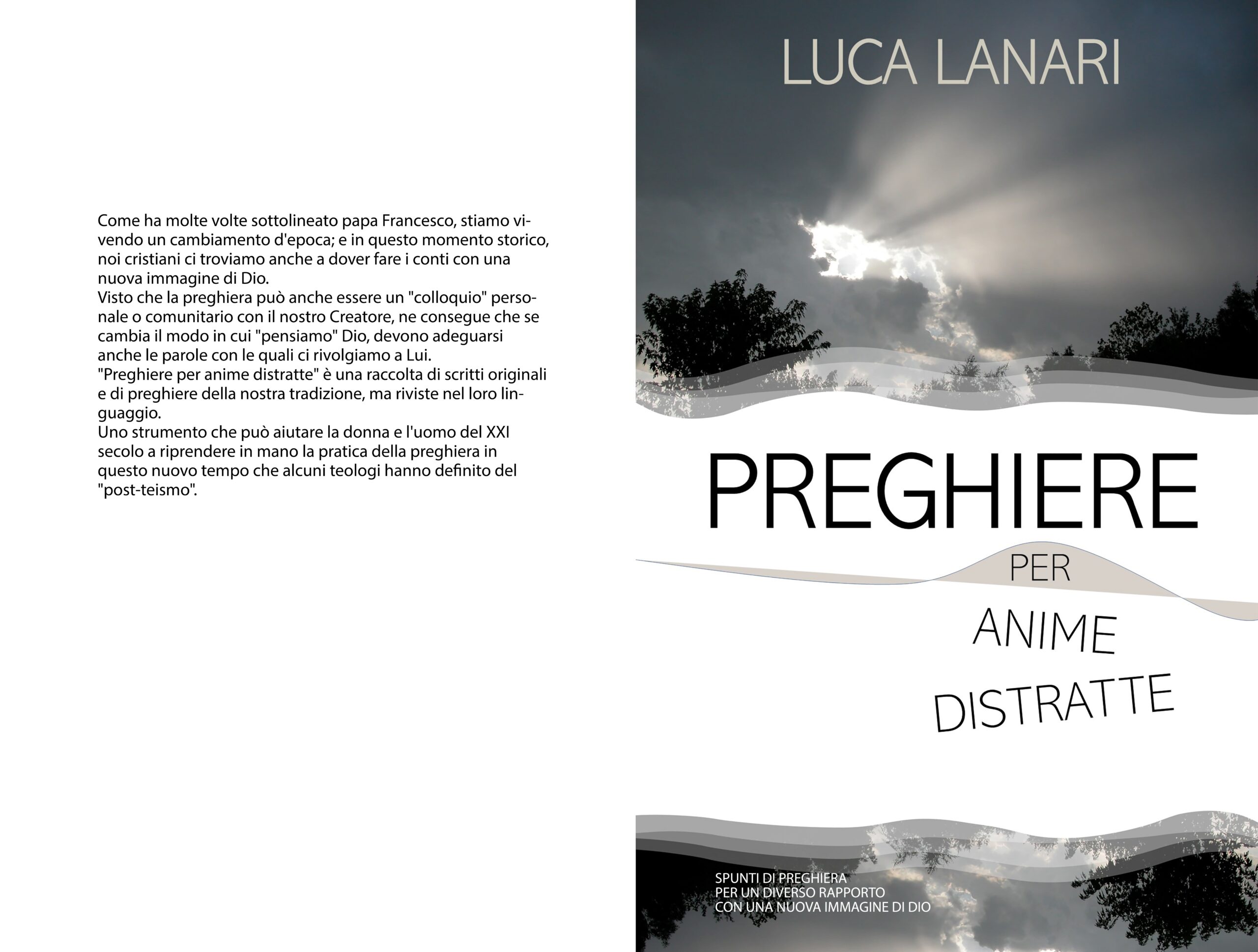Nella fine è l’inizio

Nella fine è l’inizio – in che mondo vivremo di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti – Il Mulino
Nel testo «Nella fine è l’inizio», i sociologi Giaccardi e Magatti espongono un’analisi della società attuale partendo da alcune criticità presenti in periodo pre-pandemico che si sono rivelate terreno fertile per lo sviluppo di ulteriori problematiche sorte con l’emergenza causata dal Covid-19.
Per ognuno di questi, che potremmo chiamare, fattori di rischio gli autori propongono un’idea di cammino, una possibilità che possa rappresentare una risposta per allontanare i problemi che si sono generati (e che potrebbero aumentare), nella certezza che al termine di questa grave crisi mondiale di stampo economico, sociale, culturale, religioso, politico e sanitario, si debba iniziare un nuovo percorso migliore di quanto fatto nel passato, pena una ricaduta in una situazione ancora peggiore di quella presente prima della crisi. Perché dopo una simile “frattura” o se ne esce migliori o se ne esce peggiori, tertium non datur. Forti dell’esperienza storica, gli autori infatti ricordano che «i passaggi storici segnati da stati di emergenza prolungati non si concludono con un ritorno al punto di partenza, bensì tendono a determinare esiti polarizzati» e ovviamente convengono nel sostenere l’ipotesi di cogliere questo che potremmo definire un “kairos”, «tempo propizio per cambiare ciò che fino al giorno prima pareva inamovibile» per dare «avvio a cicli storici nuovi, innervati da riferimenti e pratiche innovative.»
Volendo utilizzare le tesi dei due sociologi per una riflessione in ambito educativo, si potrebbero raccogliere le indicazioni che nascono dalle cinque parole (resilienza, interindipendenza, responsività, cura, pro-tensione) che vengono proposte come risposte ad altrettante criticità della nostra società (società del rischio, della connessione, della libertà, della potenza e dell’incertezza).
Partendo dal concetto di “resilienza” così come esposto dagli autori e applicandolo in ambito educativo dovremmo verificare se il mondo dell’educazione è riuscito ad assorbire l’urto, se è riuscito o riuscirà ad adattarsi e/o di trasformarsi per fare in modo che quando tutto sarà finito, si potranno vedere i primi effetti di un nuovo modo di educare. Poiché stiamo parlando di una società del rischio, appare necessario assumerlo, non negarlo pensando a un rischio zero, nella consapevolezza di doverci convivere ma con un mutato rapporto. E’ necessario quindi correre il rischio senza «limitarsi ad aspettare, tuttalpiù con qualche piccolo aggiustamento, di poter ripartire» occorre invece «riconoscere l’inadeguatezza del modello costruito fin qui e cominciare a sperimentare nuove soluzioni»
Se hanno ragione Giaccardi e Magatti nel sostenere che la pandemia ci ha mostrato come l’umanità sia strettamente interconnessa, che «nessun limite, nessun confine è di per sé assoluto; ne si può pensare di vivere a prescindere da ciò che ci circonda», appare evidente come anche nella sfera educativa sia necessario sposare l’idea che «ogni singolarità contribuisce in modo irrinunciabile all’insieme» e tenere sempre a mente che ogni rapporto con l’altro è sempre un incontro. Questo non significa abbandonare la propria libertà, ma diventa necessario assumere il paradosso che ci si presenta e cioè quello di essere autonomi e al contempo dipendenti. Da qui nasce la strada dell’ interindipendenza da percorrere se si vogliono abbattere i confini che ci siamo costruiti attorno. Un cammino che si snoda simultaneamente tra libertà e legame, «un’aticolazione tra sé e l’altro da sé» riconoscendo che due soggettività che si incontrano percepiscono di essere «l’una condizione per lo sviluppo dell’altra». Anche questa strada indicata dagli autori del testo, ha la caratteristica di essere appena tracciata, ma possiede la bellezza della novità perché «la società dell’interdipendenza è ancora tutta da costruire».
Assumere il valore dell’interdipendenza significa anche superare «uno dei problemi di fondo della cultura contemporanea» che è «quello di avere sgravato l’individuo dalla responsabilità delle proprie azioni». L’educazione è, a mio avviso, un mondo dove è basilare riconoscere la propria responsabilità optando per quella che Weber chiama «etica della responsabilità» che si fa carico dei suoi effetti, abbandonando quella che lo stesso definisce «etica della convinzione» che si attiene ai principi senza darsi cura delle conseguenze.
Ma il testo va ancora più in là rispetto al concetto di responsabilità e propone una “responsività” che è un’incarnazione della responsabilità all’interno della relazione stessa che ci costituisce come persone. E’ un dovere «inteso come non poter fare altrimenti» e «nasce dalla consapevolezza che le nostre decisioni hanno sempre conseguenze su chi ci sta intorno e sul mondo che abitiamo.»
E’ molto bella la metafora che paragona la responsività ad «un pioniere che si muove laddove mancano ancora le mappe.» Forse l’educazione dovrebbe avere sempre, in ogni momento, a prescindere dalle pandemie o dalle emergenze, questa caratteristica. Gli educatori si spingono oltre senza sapere in partenza dove quell’esplorazione li porterà, ma non procedono a caso, i loro passi sono guidati dalla conoscenza del luogo sul quale si trovano; non hanno mappe, ma conoscono il tipo di percorso e si attrezzano in maniera adeguata. Mutuando le parole di Ivo Lizzola, gli educatori hanno il dovere di “costruirsi” i loro sandali (il sapere, il metodo ecc.) ma poi quegli stessi calzari vanno tolti, appoggiati a terra per avvicinarsi scalzi in punta di piedi all’altro/a, ognuno ha la sua storia, la sua fragilità.
Anche in questo atteggiamento vedo un grosso stimolo per tutti gli educatori che nello svolgere responsabilmente il proprio compito devono ricordare che la responsività «è il contrario della ripetizione, dell’inerzia, della reazione ed è capace di rispondere alle sfide della situazione con gesti inediti e cambiamenti anche radicali».
Nel capitolo che parla della logica sacrificale della società tecnica, si sottolinea come la nostra società, pervasa da una crescente volontà di potenza, si riscopra invece, a causa della pandemia, in tutta la sua fragilità. Una fragilità che riguarda l’umanità intera. E in questa ottica di difendere la fragilità il testo propone di intraprendere la strada della “cura”. Guardandola come una possibilità di «trasformare gli accadimenti in esperienza, a prendere forma e dare forma al mondo, a diventare sé stesso nello scambio costante con l’altro da sé». Uno dei problemi di questo nostro tempo è quello del ritrovarci in un mondo che corre veloce «in cui siamo abituati a seguire protocolli e procedure e a ridurre il desiderio a consumo» e dove si compiono azioni, si creano situazioni in cui siamo fisicamente presenti ma in realtà “non ci siamo”, il nostro essere non è lì, talmente abituati a una vita “multitasking”. Invece «prendersi cura è un modo diverso di pensare il nostro rapporto con la realtà», è un mettere in campo tutto noi stessi, mettere in gioco il nostro essere perché «la cura è un compromettersi con l’altro». Solitamente il termine “cura” ha una certa attinenza, nei nostri ragionamenti con la parola “guarigione”. Ma Ivo Lizzola mette in guardia chi pensa di curare l’altro per portarlo alla guarigione, perché la guarigione non è di competenza di chi cura, non è nelle sue mani, ma è sempre nelle mani di chi riceve le attenzioni. Chi educa “lascia andare”. Chi educa deve “consegnare un sogno” e lo deve fare perché a prescindere dal trauma della pandemia con tutto quello che ne è conseguito, sappiamo comunque di essere creature che vivono in un’angoscia che nasce dall’avere una «percezione di una chiusura del futuro» e dallo sperimentare «la perdita del senso di comunanza». Per vincere questo senso di angoscia che caratterizza la società dell’incertezza abbiamo bisogno di fiducia. Una fiducia che sarà la giusta compagna nel cammino della responsività di cui sopra, e cioè la «capacità di fare passi che non sono già assicurati». Una fiducia che è ancor di più “affidamento” e che ci chiede di spingerci ancora oltre fino a raggiungere la “protensione” e cioè «la capacità positiva di proiettarsi in avanti, di anticipare ciò che non è stato ancora percepito; e che diventa, poi, capacità di trascendere individualmente e collettivamente i limiti di noi stessi e dei mondi sociali che abbiamo costruito, diventati evidenti nella fase dell’emergenza». Torniamo sempre a indicare una strada che conduce all’altro perché «Pro è in avanti, ma anche per e con altri.»
«La pandemia è stata una (dolorosa) palestra dove abbiamo visto che è possibile trasformare la de-tenzione (il confinamento forzato) in pro-tensione: slancio di reinvenzione del quotidiano e di sollecitudine per altri.»
Credo che in questo momento le aspettative di ognuno di noi siano legate ad una speranza di miglioramento. E’ utile allora ricordare, in chiusura, una citazione presente nel libro della coppia di sociologi. E’ una frase di Václav Havel proprio legata alla speranza e recita così:
«La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo.
Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene,
ma la certezza che quella cosa ha un senso,
indipendentemente da come andrà a finire»